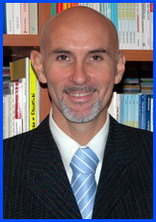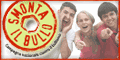|
|
|
|
| ANALISI TRANSAZIONALE PER EDUCARE |
|
1. LA PERSONALITÀ IN A.T. a. Gli stati dell'Io Uno dei concetti fondamentali dell'Analisi Transazionale è il MODELLO DEGLI STATI DELL’IO (MODELLO GAB). Uno stato dell'Io è un insieme di comportamenti, pensieri ed emozioni attraverso cui si manifesta la nostra personalità in un dato momento. Ed è proprio tale maniera di reagire che darà vita a quelle transazioni, ovvero scambi di informazioni e di sentimenti, che sono oggetto di studio dell'A.T.. Secondo questo modello esistono tre stati dell'Io distinti, più semplicemente, tre modi di porsi nei confronti degli altri. Quando una persona reagisce in maniera razionale ad uno stimolo esterno utilizzando, cioè, tutte le capacità che ha a sua disposizione in modo adulto, si dice che si trova nello stato dell'Io Io Adulto Adulto. Se invece reagisce in maniera paternalistica servendosi di comportamenti, pensieri e sentimenti copiati dai propri genitori o da figure genitoriali di riferimento, diciamo che si trova nello stato dell'Io Genitore. Quando, infine, reagisce in modo infantile come faceva quand'era bimbo, diciamo che la persona si trova nello stato dell'Io Bambino. Questi tre differenti stati dell'Io rappresentano la struttura della personalità di ogni persona e vengono convenzionalmente diagrammati come un insieme di tre cerchi l'uno al di sopra dell'altro. Essi sono presenti in ogni persona, a prescindere dalla sua età anagrafica, e sono attivati dal riascolto di registrazioni cerebrali di eventi accaduti in passato conferendo così alla personalità una struttura sana ed equilibrata. Accanto al menzionato modello degli stati dell'Io troviamo versioni più dettagliate di tale modello che considerano gli stati dell'Io in termini di struttura o di funzione. Il modello strutturale degli stati dell'Io si interessa del loro contenuto, mentre il modello funzionale si interessa del loro processo, più precisamente suddivide i vari stati dell'Io per permettere di vedere in che modo vengono da noi utilizzati.
Stato dell'Io Genitore
Stato dell’Io Adulto
Stato dell’Io Bambino
Per sapere, quanto ognuna di queste parti funzionali è importante nella nostra personalità possiamo utilizzare l'Egogramma elaborato da J. Dusay. Esso è una rappresentazione grafica e comparativa del modo in cui una persona si percepisce o è percepita dagli altri. Ne esiste una varietà infinita e nessuno somiglia all'altro, anche se tutti hanno in comune determinate caratteristiche. E' importante sottolineare che l'essenza dell'egogramma consiste nel fatto che esso deve essere utilizzato nel tentativo di conoscere meglio sé stessi in vista di futuri cambiamenti e di una futura crescita psicologica.
b. Contaminazione ed Esclusione Distinguere nettamente uno stato dell'Io dall'altro non è sempre possibile, così come non lo è passare di propria volontà da uno all'altro. In effetti, può accadere che uno di essi sia intimamente mescolato ad un altro oppure che una persona non riesca ad entrare o ad uscire fluidamente da un dato stato dell'Io. Si verificheranno, pertanto, quei fenomeni psicologici che E. Berne ha definito CONTAMINAZIONE ED ESCLUSIONE.
territorio di un altro. A): La contaminazione dell'Adulto da parte del Genitore implica che un individuo scambi erroneamente slogan genitoriali (peculiari) per una realtà dell'Adulto. Rientrano in questa casistica tutti quei pregiudizi e quelle credenze che, per troppo tempo nutriti e non contraddetti, hanno finito per venire considerati altrettante verità: "I meridionali sono pigri". "Meglio non fidarsi degli altri". "Il padrone ti sfrutta", e così via. B): Si ha contaminazione dell'Adulto da parte del Bambino quando un individuo fa affiorare alla propria coscienza convinzioni consolidatesi durante la Iª infanzia ad esempio: il timore che gli altri ridano alle sue spalle. La contaminazione del Bambino, tuttavia, investe una sfera più ampia, come il rimanere ancorato a quelle che Berne chiama Idee Fisse: "Non sono fatto per imparare le lingue." "Non riuscirò mai a smettere di fumare." "Sono nato grasso," e così via. C): La doppia contaminazione dell'Adulto, infine, chiama in causa contemporaneamente gli altri due stati dell'Io, nel senso che l'individuo ripropone uno slogan Genitoriale, cui si adegua tramite una credenza da Bambino e scambia entrambe queste cose per la realtà. Per esempio: (G) "E' dimostrato che le donne non pensano." (B) "Alla larga dalle bimbe." (A) "Meglio non fidarsi delle donne." Con l'esclusione, invece, uno o due stati dell'Io dominano il comportamento di una persona. Questi stati dell'Io vengono definiti costanti o escludenti.
In linea di massima, si può affermare quanto segue: · Una persona con un Genitore costante affronterà il mondo unicamente attraverso un insieme di regole genitoriali, come capita ad esempio agli insegnanti, ai medici, infermieri, ecc., che tendono a fare prediche e a volte, a sconfinare nell'autoritarismo. · L'Adulto costante, tende a mettere in secondo piano la propria emotività e a funzionare proprio come un calcolatore elettronico. Molti scienziati, soprattutto nel campo della ricerca e sperimentazione, hanno questo Adulto costante. · Chiunque, infine, si trova nel Bambino costante penserà, si comporterà e sentirà sempre come se fosse ancora nell'infanzia (Sindrome di Peter Pan). Riterrà, ad esempio, che sia suo compito specifico divertire la gente. Questa è una situazione peculiare a tutti coloro che operano nel mondo dello spettacolo. Accade, tuttavia, che molti individui utilizzino fondamentalmente soltanto due dei loro stati dell'Io, escludendo il terzo. · Coloro che escludono il Genitore tendono a rifiutare le regole già stabilite e preferiscono crearsene di nuove. Sono molto bravi a servirsi del loro Bambino creativo (Piccolo Professore) per afferrare al volo quanto avviene intorno a loro e ad adeguarvisi. Sono i cosiddetti «volponi» e possono essere: dei politici di razza, dei manager di successo, ma anche dei mafiosi di alto bordo. · Coloro che escludono l'Adulto sono privi della capacità di esaminare oggettivamente la realtà. Dentro loro si svolge un continuo dialogo tra Genitore e Bambino, finalizzato all'esplicitazione di sentimenti e azioni che possono anche apparire bizzarri, in quanto spesso avulsi dalla realtà concreta. Di solito, questa esclusione è di tipo patologico e caratterizza, ad esempio, coloro che soffrono di Psicosi Maniaco- Depressiva, i quali alternano periodi di sovreccitazione fanciullesca a periodi di oppressività genitoriale. · Coloro che, infine, escludono il Bambino lo fanno prevalentemente a fini difensivi e, pertanto, tendono a cancellare i ricordi immagazzinati della propria infanzia e i sentimenti ad essi correlati. E' l'atteggiamento classico del «freddo calcolatore» o del «narcisista».
Essa è uno scambio qualificato e caratteristico tra due persone o, più esattamente, tra un mittente che, attivando un proprio stato dell'Io, si rivolge ad uno degli stati dell'Io del destinatario (stimolo Transazionale), e da un destinatario che, a sua volta, reagirà a partire da un proprio stato dell'Io rivolgendosi ad uno degli stati dell'Io dell'altro (reazione Transazionale). L'A.T., nella sua espressione più semplice, si occupa di diagnosticare quale stato dell'Io ha provocato lo stimolo transazionale e quale ha messo in moto la reazione transazionale. Se ne può agevolmente dedurre che un rapporto sociale, di cui la transazione è l'unità fondamentale unità fondamentale, è caratterizzata, appunto, da una successione di transazioni il cui studio può consentire di comprendere meglio il fenomeno comunicazione. Le transazioni possono essere: complementari, incrociate e ulteriori e riconducibili alle tre regole fondamentali della comunicazione di E. Berne. La Iª regola della comunicazione afferma che una transazione complementare ha la caratteristica di essere prevedibile e fintantoché la transazione rimarrà complementare, non ci sarà nulla nel processo di comunicazione che potrà interrompere il flusso ininterrotto tra S e R o, almeno, fino a quando non sarà stato raggiunto lo scopo desiderato. I vettori transazionali sono paralleli e lo stato dell'Io cui la persona si rivolge è quello Adulto che risponderà. Possiamo, tuttavia, produrre tre altre possibilità di transazione complementare: quella da Genitore a Bambino, da Genitore a Genitore e da Bambino a Bambino. La IIª regola della comunicazione dice che una transazione è incrociata quando il dialogo si interrompe prima del raggiungimento dello scopo, a meno che uno dei due o entrambi gli interlocutori non decidano di passare da uno stato dell'Io ad un altro affinché il dialogo possa essere ristabilito. In questa situazione i vettori transazionali non sono più paralleli ma incrociati e che lo stato dell'Io a cui ci si rivolge non è quello che risponde, provocando una reazione inattesa. Infine, la IIIª regola della comunicazione sostiene che in una transazione ulteriore vengono trasmessi contemporaneamente un messaggio manifesto o a livello sociale, e un messaggio segreto o a livello psicologico e che l'esito in termini comportamentali di questa transazione è determinato a livello psicologico e non a quello sociale. In altre parole Berne sottolinea il fatto che se si vuole capire il comportamento bisogna prestare attenzione al livello psicologico della comunicazione. Lo possiamo fare attraverso quello che Berne chiama "pensiero marziano" che privilegia l'osservazione dei segnali non verbali utilizzati durante la comunicazione. Li troviamo nel tono di voce, nei gesti, nelle espressioni dell'atteggiamento corporeo e facciale, nella respirazione, sudorazione e così via. Ogni transazione, in verità, ha un livello psicologico (messaggi segreti) oltreché un livello sociale (messaggi manifesti). Ma in una transazione ulteriore le due cose non collimano. I messaggi trasmessi dalle parole sono contraddetti dai messaggi non verbali.
aspetto dell'A.T. Esso indica un programma di vita inconscio costruito su una decisione presa durante l'infanzia, rinforzata dai genitori e giustificata dai successivi eventi, che culmina in una scelta decisiva. (E. Berne, Ciao!… E poi? p. 272) Ciascuno di noi, dunque, vivendo scrive ed interpreta una sorta di copione le cui istruzioni vengono registrate nello stato dell'Io Bambino per effetto delle transazioni che avvengono tra lui e i suoi genitori. Il concetto, tuttavia, è molto più ampio, e possiamo distinguere tra copioni culturali, sub-culturali e familiari. I primi sono quelli che affondano le loro radici nella cultura in cui gli individui nascono e si sviluppano. Ogni cultura ha il proprio tema di copione: la conquista militare per gli antichi romani, la diversità e sofferenza per il popolo ebraico, la lotta per la sopravvivenza dei pionieri americani, e così via. I secondi si sviluppano all'interno di una determinata cultura ma non accettati dalla totalità di questa. Il razzismo, anche semplicemente come contrasto tra nord e sud, potrebbe esserne un esempio quanto mai preciso ed attuale. I terzi, infine, vengono sviluppati all'interno di alcune famiglie per poi esercitare pressioni sui figli affinché ne interpretino i ruoli. Molti di questi copioni, che possono essere identificati con frasi classiche: “Noi Rossi, non abbiamo mai chiesto niente a nessuno”, hanno finalità generiche e si traducono in comportamenti esistenziali. Sono convinzioni che l'individuo accetta acriticamente (più precisamente il bambino durante la Iª infanzia) e che si porterà appresso per tutta la vita. Tuttavia, per meglio comprendere il copione è bene analizzare la definizione data da E. Berne già sopracitata. In tale definizione troviamo inseriti alcuni elementi rilevanti quali: l'elemento piano di vita, l'elemento rinforzo genitoriale, l'elemento culmine e l'elemento decisione. 1): Ciò in cui la teoria del copione dell'A.T. si differenzia dagli altri è nel sostenere che il bambino componga, più o meno consapevolmente, un piano specifico della propria vita, più che semplicemente una visione generale del mondo. Questo piano di vita, dice la teoria, viene composto sotto forma d'azione drammatica, con una sua introduzione, uno sviluppo e una conclusione. 2): I genitori anche se non sono in grado di determinare le decisioni di copione del bambino, di certo le influenzano fortemente lanciandogli ripetutamente quei messaggi verbali già sopra riportati. Va, tuttavia, sottolineato che tali messaggi vengono completati e rinforzati anche da componenti non verbali, conformi all'atmosfera in cui il bambino cresce ed agli atteggiamenti di coloro che lo circondano. 3): Il copione in quanto azione drammatica deve culminare in qualcosa, cioè in una conclusione, in una sorta di apoteosi. Secondo l'A.T., il bambino non si limita a scrivere il copione in quanto tale, ma scrive anche la scena finale; e non è da escludere che tutte le varianti e aggiustamenti successivi, messi in atto in età adulta, mirino soprattutto alla realizzazione di quella scena finale (tornaconto del copione copione). 4): L'ultimo elemento, la decisione, merita una particolare attenzione in quanto racchiude in sé una differenziazione assoluta dalle teorie del behaviorismo, che, come sappiamo, postula l'importanza determinante dell'ambiente per gli sviluppi futuri dell'individuo. Invece, secondo le osservazioni pratiche di Berne, quindi trasferite nella teoria transazionale, due bambini, nati nella medesima famiglia e vissuti nello stesso ambiente, possono elaborare copioni di vita totalmente diversi. Va, tuttavia, precisato che, in A.T., il termine decisione va colto in una sua accezione particolare, più emotiva che razionale. Infatti, le decisioni di copione del bimbo non sono prese nel modo riflessivo e determinato che normalmente associamo alle decisioni prese dall'adulto ma da un esame prevalentemente emotivo della realtà in cui il bimbo agisce. Perciò, sono importanti i primissimi anni di vita di un individuo e soprattutto le prime esperienze inconsapevoli che un neonato fa in rapporto agli altri per la costruzione iniziale del copione. Durante il corso di vita di un individuo il copione da lui elaborato potrà rivelarsi difficilmente applicabile. L'Adulto, dovrà allora scegliere tra impuntarsi a realizzarlo, portandosi dietro la frustrazione di non aver dato continuazione alle proprie aspirazioni più genuine, o modificarlo, trascinandosi appresso il rammarico di avere frustrato le aspettative risposte in lui dalle figure genitoriali che hanno contribuito a scriverlo. Più semplicemente, che sarà l'Adulto a dovere fare i conti con sé stesso e, di fatto, con gli altri due stati dell'Io (Genitore, Bambino). In quest'ottica, M. Janes e D. Jongewaard, due allieve di Berne hanno elaborato i concetti di vincente e di perdente. (Copione vincente e Copione perdente perdente) Sintetizzando le conclusioni cui sono giunte le due autrici, possiamo dire che è vincente colui il quale sta bene nei propri panni, mentre è perdente colui che vorrebbe stare nei panni di qualcun altro. Possiamo concludere con due dichiarazioni di principio particolarmente
significative: e. I Giochi Psicologici
assimilabile a una transazione duplice o ulteriore, perché si sviluppa contemporaneamente sia a un livello sociale che psicologico, del quale, come sappiamo, dal capitolo dedicato alle transazioni, sono consapevoli soltanto i due interlocutori; o per meglio dire, giocatori che giocano consapevolmente sul solo livello sociale. Ai fini dell'interpretazione dei giochi, è interessante la teoria di S. Karpmann secondo il quale in tutti i giochi gli interlocutori, anche se sono soltanto due, interpretano tre ruoli di copione, così denominati: · Persecutore (P) · Salvatore (S) · Vittima (V) Il persecutore considera gli altri inferiori a lui e non OK e lo stesso fa il salvatore con la differenza però che reagirà offrendo loro aiuto da una posizione di superiorità. Una vittima è una persona che si considera inferiore e non OK. I giochi che prendono l'avvio da questo ruolo tendono a rinforzare l'immagine negativa che uno ha di sé stesso: Io non sono OK e, quindi, devo essere punito o salvato. All'origine del ruolo c'è, ovviamente, una svalutazione. Questi tre ruoli danno vita ad un diagramma triangolare, dove ciascuno di essi occupa un vertice e che, pertanto, è stato denominato "Triangolo drammatico di Karpmann".
L'aspetto più interessante del triangolo di Karpmann è che ciascuno dei due interlocutori può passare da un ruolo all'altro. Questo passaggio avviene solitamente nel momento in cui il gioco arriva al colpo di scena scena; una volta agganciata la vittima, il giocatore cambia mossa e capovolge la situazione per ottenere il desiderato tornaconto (FINE, solitamente negativo, cui tende il gioco). Nel corso di un medesimo gioco, tale capovolgimento di situazione può avvenire più volte. Il livello sociale A- - > A viene abbandonato balzando in primo piano le transazioni G - -> B e B - -> G. Per uscire da un qualsiasi gioco, una persona dovrà attivare il suo Io Adulto che la porterà ad instaurare una transazione complementare orizzontale A - - > A che produrrà risultati concreti risolvendo così ogni problema. Interessante è evidenziare come, a volte, un Educatore può attivare inconsciamente questa triangolazione (P, S, V.) durante la sua attività educativa. Concludendo, è evidente come tali giochi psicologici (dinamiche nevrotiche che seguono la IIIª regola della comunicazione di E. Berne) influenzino negativamente la relazione educativa.
CONCLUSIONI Da quanto sopradescritto si può evincere che l'utilità dell'A.T. per l’Educatore può essere riassunta nei seguenti tre punti:
A) La capacità e la competenza di saper analizzare le personalità di tutte le parti coinvolte nelle situazioni educative (famiglia, gruppo…) insieme alle dinamiche interpersonali che si sviluppano in itinere. B) Sapere utilizzare lo stato dell'Io adatto alle diverse fasi del processo educativo; ad esempio l'energizzazione del Genitore Affettivo per rassicurare l’educando, o del bambino libero per creare complicità, etc… C) Il sapersi porre nella relazione educativa mantenendo uno stato dell'Io Adulto lucido e razionale, ossia non condizionato da eventuali dinamiche nevrotiche (Giochi Psicologici). *Estratto dal sito IAT di Roma www.sieb.org |
|
|
|
Prenota |